“A complete unknown”, di James Mangold è da poco nelle sale cinematografiche italiane, sia in versione originale (consigliata) che in versione tradotta. Ripercorre la storia di Bob Dylan dagli esordi – 1961 – sino al 1965. Un grande film su un potente periodo della storia statunitense sia musicale che politica e sociale ma soprattutto sulla complessa figura di questo grande della musica mondiale. Abbiamo ricevuto e volentieri riportiamo una interessante e competente recensione di Marco Rigamo. Buona lettura.
Il cambiamento è il risultato del coraggio. James Mangold
Sono pedante, lo so. Per attraversare A Complete Unknown, ultimo lavoro di James Mangold, è imprescindibile dribblare l’orrendo doppiaggio italiano e affrontare la versione originale sottotitolata, scongiurando così lo straniamento provocato dal passaggio al cantato, che è tanta roba. Percependo immediatamente quanto Dylan c’è nella recitazione di questa divisiva giovane star che con encomiabile sprezzo del pericolo si è imbarcata nel progetto. Il titolo viene dalla quarta strofa del riff di Like A Rolling Stone: Un Perfetto Sconosciuto. E’ proprio questo che incarna quel ventenne che scende dal portellone posteriore di una Cevy station wagon mentre l’inverno di New York City volge al termine. Arriva da Hibbing, Minnesota, con una chitarra in un astuccio e uno zaino di ballate un po’ tristi. Tra queste ce ne è una intitolata Song to Woody. Bobby vuole andarlo a trovare al Greystone Park Hospital, nel New Jersey, da dove è appena arrivato. Malattia di Huntington, congenita, trattata con buona quantità di alcol e scarsa fortuna farmacologica. Sulla chitarra di Woody Guthrie c’è scritto This Machine Kills Fscists, ma questa ormai è acqua passata. Ha lo sguardo dolorosamente stupefatto, non riesce più a pronunciare una parola, sa ancora ascoltare. In realtà dice tantissimo. Per raggiungerlo è passato davanti al Cafè Wha e si è fermato in un bar, giusto il tempo di farci vivere com’erano Manhattan e il Village nel 1961 attraverso la millimetrica precisione filologica di Mangold. Pochi elementari accordi di quel ragazzino sconosciuto bastano a Seeger per ricordarci che Edward Norton è un grandissimo e a Guthrie per farci ricordare anche dopo la fine Scoot McNairy. Fino a qui tutti dovremmo sapere tutto.

Istintivamente cerchiamo le connessioni. Le dita sulla tastiera, le guance che soffiano nell’armonica, la voce: sono davvero quelle di Timotée Chalamet. Norton suona realmente con invidiabile scioltezza il banjo. Ma Chalamet può davvero passare da Dune al mostro sacro Dylan? Mangold può davvero passare da Walk The Line, dove si giocava l’indiscutibile asso pigliatutto Joaquin Phoenix nel ruolo di Johnny Cash, a questo idolo delle giovani donne, piuttosto patinato e talvolta francamente stucchevole? L’ascolteremo più tardi, ma: Don’t Think Twice, It’s All Right. Possiamo perciò velocemente scavalcare il geniale I’m Not There di Todd Hynes senza dimenticarci di metterne a valore il titolo: in sottofinale troveremo un Dylan copia conforme di quella stupefacente Cate Blanchett che fu molto più Dylan di tutti gli altri cinque blasonati colleghi, e per tutta la proiezione avremo a che fare con un Dylan che non c’è. Perché questo ragazzo cresciuto a Duluth, che forse ha imparato i primi accordi in un circo itinerante da un cowboy – o forse no, forse è una balla – non c è mai. E’ sempre altrove, in un continuo slittamento, sempre ingaggiato in uno spostamento with no direction home. Sempre immerso in un irresistibile bisogno di cambiamento. Nella ineludibile necessità di tradire tutti per non tradire se stesso.
Da Pete Seeger che gli apre la strada a Woody Guthrie che gliela ha indicata per primo. Da Albert Grossman che lo ha lanciato nell’industria discografica ad Alan Lomax che lo ha voluto sul palco di Newport. Dal primo amore Sylvie Russo, translitterazione dilatata nel tempo e nello spazio di Suze Rotolo, la ragazza della copertina di The Freewhelin’ all’amore complicato e tumultuoso Joan Baez, già solida icona della musica country più impegnata. Doverosa sottolineatura per queste due. Se Elle Fanning è in grado fin da piccola di illuminare di luce propria qualsiasi personaggio interpreti, quindi nessuno stupore, la semisconosciuta Monica Barbaro, oltre a suonare la chitarra e cantare senza mostrare soggezione alcuna verso l’originale, ogni volta che appare provoca uno tsunami. Quando mettendo su il caffè sibila a Bob sai che sei proprio uno stronzo lui le risponde sì, poi tutti e due ci regalano la prima mondiale di Blowin’ In The Wind: osservare come lei gli si avvicina, come accenna e poi rinforza la controvoce, come lo guarda di taglio, gli occhi a pochi centimetri dai suoi. Alla fine gli chiede: e questo, che cos’è? Lui risponde, finalmente guardandola dal basso verso l’alto: non lo so. E nemmeno noi sappiamo di cosa stiano parlando. Amore, guerra, libertà, il destino dell’Uomo, il senso della Vita? O forse sì: è più di mezzo secolo che la risposta è nel vento.

L’unico che passa indenne in mezzo ai tradimenti è Johnny Cash. Poco dopo l’inizio Bob lo ascolta alla radio in automobile con Pete Seeger, in una conversazione che è la prima avvisaglia della sua inquietudine, della sua insofferenza nascente verso il perimetro coercitivo della musica folk. Boyd Holbrook fa un Johnny Cash strafottente e inzuppato di birra e anche per lui Mangold si concede una licenza artistica facendolo salire sul palco di Newport ’65. E’ qui la cerniera con Walk The Line: anche Bob Dylan tira dritto, sfida il destino mettendo in scena la sua (provvisoria, la prima di molte altre) trasformazione. Ha cambiato sguardo, postura, camminata. Musica, volume, strumento. Come sia andata è noto anche alle anagrafiche più recenti. A quelli che lo avevano osannato l’anno precedente, gli stessi che cantavano in coro che I Tempi Stanno Cambiando senza avere mai sentito prima il brano, grida in faccia che non ne può più di restare nella Maggie’s Farm, imbracciando una elettrica Fender Stratocaster dopo che una band di rockettari della risma di Mike Bloomfield e Al Kooper ha raccolto con gioia il suo invito ad alzare al massimo il fottuto volume. Bob scansa gli ortaggi che gli arrivano da quella parte del pubblico che non si è alzata in piedi a ballare e sulle ultime note di Like A Rolling Stone (sei minuti, un altro fuori misura per l’epoca) se ne vuole andare. Cash lo dissuade senza quasi dire parola, completa il passaggio di testimone mettendogli in mano la sua acustica folk: It’s All Over Now, Baby Blue. E’ davvero finita. Manca solo un’ ultima visita al capezzale di Woody per un gesto che non si può raccontare, sigillando la consegna delle armi definitiva. Poi di corsa via da tutto e da tutti in sella alla sua Triumph. I Dylaniani motociclisti sanno che un anno dopo con quella moto “avrebbe avuto” un grave incidente. Di segnalazione del fatto alla polizia stradale e di arrivo di ambulanze non c’è traccia. Dell’annullamento dell’imminente tour e della sua lontananza dai concerti per i successivi sette anni invece sì.

E noi? Noi, parafrasando al contrario il titolo di Todd Hynes, siamo ancora qui. Non quelli che aspettano di vedere questo scampolo di biopic in streaming sul loro laptop, non quelli che in sala sono infastiditi dai sottotitoli perché l’ inglese lo conoscono bene. Noi siamo quelli che le immagini in bianco e nero che appaiono nei televisori in secondo piano le hanno viste tutte quando ancora andavano a scuola. La crisi dei missili a Cuba, Kennedy, Martin Luther King, Selma, Berkeley. Siamo quelli che trascinavano nella polvere dei marciapiedi le bandiere stelle e strisce nei cortei contro la guerra in Vietnam, quelli che hanno edificato una significativa parte di sé anche in ragione dell’ascolto di quelle ballate. Quando nel ’69 uscì Nashville Skyline una mia compagna del liceo mostrandomi la copertina mi disse guarda: è cambiato. Dylan alzandosi il cappello sopra la testa sorprendentemente sorrideva guardando in macchina, in compagnia di una chitarra folk. Non era quello l’unico cambiamento. Mentre band come i Grateful Dead e i Velvet Undrground sperimentavano allargando i confini della musica, mentre Jimi Hendrix chiudeva i tre giorni di Woodstock straziando l’inno nazionale americano, Dylan era tornato a un country profondamente intriso di rock, incidendo quella raccolta in quattro giorni, la prima traccia insieme al vecchio amico Johnny Cash. Lo vedremo qualche anno dopo con la faccia dipinta nella Rolling Thunder Revue suonare ancora una Stratocaster cambiando tempi e modi delle sue liriche. E poi ancora e ancora sempre diverso. Quindi possiamo dire che – noi – siamo stati fortunati, anche se dobbiamo continuare a chiederci “quante volte ancora devono volare le palle di cannone, prima che siano bandite per sempre”. Noi siamo ancora qui, anche se – loro – i Signori della Guerra, loro non se ne sono mai andati.
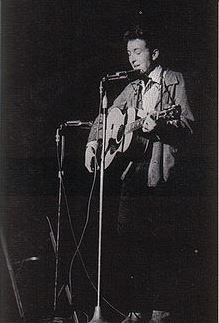
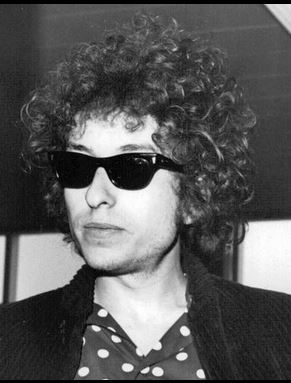


Approfondita, documentata e convincente recensione.In sintesi: grazie per questo sguardo sul film.